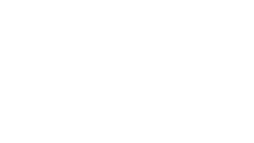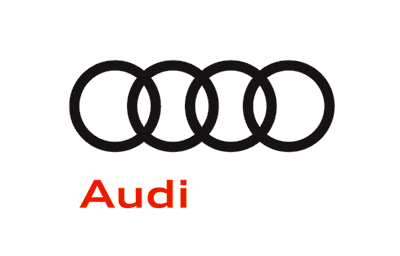- Home
- ST. MORITZ 1948, IN TRIPUDIO PER NINO BIBBIA
ST. MORITZ 1948, IN TRIPUDIO PER NINO BIBBIA

Nel 1948 i Giochi invernali tornarono a St. Moritz, a vent’anni di distanza dalla prima edizione ospitata dagli svizzeri e ci tornarono con alcune novità geopolitiche. Germania e Giappone furono esclusi dalle gare: era ancora troppo caldo il fuoco delle bombe che avevano devastato mezzo mondo. Rientrò, invece, l’Austria, che era stata assorbita nel ’36 dal Reich. Gli anni della guerra si erano portati via molti protagonisti degli sport invernali, che avevano prestato servizio nei rispettivi eserciti. Come non menzionare Pepi Jennewein, pilota e discesista, che trovò la sua fine nei cieli dell’Unione Sovietica, così come Harro Crantz, fratello della grandissima Cristl.
L’Italia tutelò meglio i suoi campioni, almeno quelli delle discipline invernali, che furono arruolati dalle Fiamme Gialle e dalla Milizia Confinaria, oppure nella Pattuglia sci veloci della Scuola Alpina di Aosta, della quale fece parte anche Zeno Colò. L’8 settembre 1943, quegli alpini si salvarono, oltrepassando il confine con i propri sci, salendo il Plateau Rosà da Cervinia e riscendendo verso Zermatt, in Svizzera. Così furono tutti salvi.
Quando, a St. Moritz, finalmente gli atleti di 28 nazioni si poterono ritrovare per gareggiare, l’atmosfera era davvero gioiosa. La cittadina dell’Engadina era in grande festa e gli azzurri potevano godere di un clima quasi di casa, vista la poca distanza da Milano e il diffuso italiano parlato per le strade. Per portare la bandiera italiana alla cerimonia di apertura fu scelto Vittorio Chierroni, vista la sua carriera e l’anzianità di servizio, anche se qualcuno avrebbe preferito Celina Seghi o Zeno Colò. Proprio Colò e Chierroni erano le due punte della squadra azzurra di sci alpino, fra i pochi che avrebbero potuto aspirare ad una medaglia, visto che gli anni della guerra avevano praticamente azzerato gli atleti di molte altre discipline.
Si cominciò con la discesa, ma Chierroni finì nella neve fresca e Colò fece la stessa fine, rompendo anche uno sci. Alla fine vinse il francese Henri Oreiller, mentre Silvio Alverà e Carlo Gartner furono sesti a pari merito. Nella gara femminile era presente anche la Seghi che terminò quarta, dopo aver visto ruzzolare i suoi due compaesani.
Grande orgoglio suscitò la prova dei fondisti nella staffetta 4 x 10 km, quando l’Italia fu sesta grazie ad una gran prova di Vincenzo Perruchon, Silvio Confortola, Rizzieri Rodeghiero e Severino Compagnoni, che tagliarono il traguardo a meno di 20 minuti dai dominatori svedesi.
La grande sorpresa, però, arrivò nello skeleton, sport piuttosto sconosciuto se non per Svizzera, Usa e Inghilterra. E arrivò grazie a Nino Bibbia. Il 24enne valtellinese, era emigrato con la famiglia in Engadina dove commerciava in frutta e verdura. Appassionato della Cresta Run, la magnifica pista naturale di St. Moritz, aveva cominciato ad appassionarsi sia al bob che allo skeleton. Quando arrivarono i giorni di gara, Bibbia sorprese il mondo e staccò i favoriti nelle sei manches su cui si gareggiò. Gli atleti portavano un casco di sughero, ginocchiere e paramani d’acciaio, ed erano dotati di lunghe unghie d’acciaio per guidare il mezzo. Così acconciati si lanciavano lungo la Cresta Run a più di cento all’ora. Un gran silenzio coronava ogni discesa e, alla fine, l’oro fu italiano. Lo aveva vinto Nino Bibbia, prima storica e preziosa medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali.

ST. MORITZ 1948, IN TRIPUDIO PER NINO BIBBIA
Nel 1948 i Giochi invernali tornarono a St. Moritz, a vent’anni di distanza dalla prima edizione ospitata dagli svizzeri e ci tornarono con alcune novità geopolitiche. Germania e Giappone furono esclusi dalle gare: era ancora troppo caldo il fuoco delle bombe che avevano devastato mezzo mondo. Rientrò, invece, l’Austria, che era stata assorbita nel ’36 dal Reich. Gli anni della guerra si erano portati via molti protagonisti degli sport invernali, che avevano prestato servizio nei rispettivi eserciti. Come non menzionare Pepi Jennewein, pilota e discesista, che trovò la sua fine nei cieli dell’Unione Sovietica, così come Harro Crantz, fratello della grandissima Cristl.
L’Italia tutelò meglio i suoi campioni, almeno quelli delle discipline invernali, che furono arruolati dalle Fiamme Gialle e dalla Milizia Confinaria, oppure nella Pattuglia sci veloci della Scuola Alpina di Aosta, della quale fece parte anche Zeno Colò. L’8 settembre 1943, quegli alpini si salvarono, oltrepassando il confine con i propri sci, salendo il Plateau Rosà da Cervinia e riscendendo verso Zermatt, in Svizzera. Così furono tutti salvi.
Quando, a St. Moritz, finalmente gli atleti di 28 nazioni si poterono ritrovare per gareggiare, l’atmosfera era davvero gioiosa. La cittadina dell’Engadina era in grande festa e gli azzurri potevano godere di un clima quasi di casa, vista la poca distanza da Milano e il diffuso italiano parlato per le strade. Per portare la bandiera italiana alla cerimonia di apertura fu scelto Vittorio Chierroni, vista la sua carriera e l’anzianità di servizio, anche se qualcuno avrebbe preferito Celina Seghi o Zeno Colò. Proprio Colò e Chierroni erano le due punte della squadra azzurra di sci alpino, fra i pochi che avrebbero potuto aspirare ad una medaglia, visto che gli anni della guerra avevano praticamente azzerato gli atleti di molte altre discipline.
Si cominciò con la discesa, ma Chierroni finì nella neve fresca e Colò fece la stessa fine, rompendo anche uno sci. Alla fine vinse il francese Henri Oreiller, mentre Silvio Alverà e Carlo Gartner furono sesti a pari merito. Nella gara femminile era presente anche la Seghi che terminò quarta, dopo aver visto ruzzolare i suoi due compaesani.
Grande orgoglio suscitò la prova dei fondisti nella staffetta 4 x 10 km, quando l’Italia fu sesta grazie ad una gran prova di Vincenzo Perruchon, Silvio Confortola, Rizzieri Rodeghiero e Severino Compagnoni, che tagliarono il traguardo a meno di 20 minuti dai dominatori svedesi.
La grande sorpresa, però, arrivò nello skeleton, sport piuttosto sconosciuto se non per Svizzera, Usa e Inghilterra. E arrivò grazie a Nino Bibbia. Il 24enne valtellinese, era emigrato con la famiglia in Engadina dove commerciava in frutta e verdura. Appassionato della Cresta Run, la magnifica pista naturale di St. Moritz, aveva cominciato ad appassionarsi sia al bob che allo skeleton. Quando arrivarono i giorni di gara, Bibbia sorprese il mondo e staccò i favoriti nelle sei manches su cui si gareggiò. Gli atleti portavano un casco di sughero, ginocchiere e paramani d’acciaio, ed erano dotati di lunghe unghie d’acciaio per guidare il mezzo. Così acconciati si lanciavano lungo la Cresta Run a più di cento all’ora. Un gran silenzio coronava ogni discesa e, alla fine, l’oro fu italiano. Lo aveva vinto Nino Bibbia, prima storica e preziosa medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali.




 WEBCAM
WEBCAM